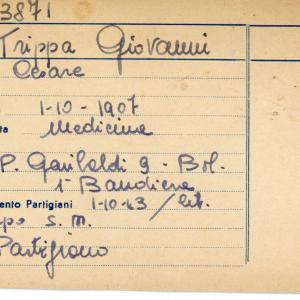Schede
Angelo l'aveva la faza ed dau séri, e la portava con molta disinvoltura tanto che lui stesso raccontava, con intelligente umorismo, che aveva già scritto sul testamento che quènd l’aré pighé i furchètt, premma d’èsar purtè da Neso (il necroforo del cimitero di Medicina) la sua faccia doveva essere consegnata all’Università di Bologna dove gli studiosi avrebbero potuto provare di capire la causa della realtà veramente sorprendente del suo viso. “La mi faza l’é da museo”, e lo affermava con un certo senso di orgoglio.
Per tutti Angélo era al rapresentènt, quello che, negli anni ’30, aveva il compito ed mèttar fòra i brènc dil don che andavano alla monda del riso o in zò a zapèr. Passava per le contrade dritto e alto sulla sua bicicletta e con voce stentorea intimava, ad esempio: “Da dmèn tótti quålli dil Chè Nóvi e dal Mazèl Vèc, al Brótti; tótti quålli d’la cuntrè dal Saul, dal Palaz Reel e dal Buci stronzi, da Pól” e, in questo modo, l’organizzazione funzionava, anche perché il passa-parola tra le interessate era veloce e preciso. Se c’erano lavoratrici con qualche primavera in più e senza la bicicletta, l’ordine diventava non più collettivo, ma personale: “La Mora la vè da Baratiéri e la Marijna a la Padalåccia”, che erano zone più vicine. Aveva anche l’incarico Angélo di interessarsi della distribuzione dei copertoni delle biciclette usate per il lavoro e della loro sostituzione, dopo averne valutato attentamente lo stato. Siccome in questa incombenza era di manica un po’ stretta e faceva qualche distinzione tra le richiedenti, le donne, tutte d’accordo, mettevano in atto una strategia che funzionava sempre. Una delle giovani, meglio se particolarmente carina, prendeva il copertone rotto o consumato dell’anziana e si recava nell’Ufficio del “rappresentante”, fingendo di avere lei la necessità improrogabile della sostituzione; la manica stretta di Angélo si allargava quasi di botto perché cun il zòvni ai passéva la gricìsia.
Bisognava usare un po’ di furbizia anche cun al fataur, al padròn e zért capurìa, perché se, camminando sull’argine in esplorazione, si accorgevano che qualcuna delle lavoratrici era sotto l’età canonica, irritati la mandavano subito a casa. “Ah quåsta po propi no”, si erano tutte organizzate le donne per non far mancare quei soldi in più alle famiglie, allora numerose e con dei meravigliosi chiari di luna int’al catuén. “Liva so i garètt di pia acsé t’ pèr pió grènda”, dicevano piano alla ragazzina, tanto, lavorando in acqua nella risaia, nessuno poteva accorgersi di niente: cercavano poi di nascondere la sua presenza clandestina nei modi più intelligenti. Durante il lavoro le insegnavano a distinguere con precisione al giavòn, l’érba mata, che danneggiava il riso, dalle piante vere, e le assicuravano la protezione necessaria per far sì che acquisisse sempre maggiore sicurezza e più tranquillità nel lavoro stesso. Era la solidarietà tra i poveri, per la sopravvivenza, come quando, per strada, una del gruppo rimasta a piedi a causa del copertone bucato, veniva prontamente caricata da una compagna sulla propria bicicletta e portata così a destinazione. Un’altra riusciva a trascinare la bicicletta infortunata, pedalando con destrezza sulla propria, anche se il vento era contrario e t’ fiv una fadìga da boia. L’abilità che avevano acquisito in questo mutuo soccorso era sorprendente gnènc da cråddar. Forse traevano energia anche dai canti collettivi all’unisono o a più voci, i trón, con i quali, durante il lavoro, esprimevano in libertà le loro pene, le loro ansie, il logorio delle loro forze fisiche, e i momenti di gioia, le speranze, i sentimenti che le animavano: erano i loro blues! Non interrompevano il canto nemmeno se scorgevano sull’argine il padrone. “Siché dònca, ragazóli, lavurègna o as divartègna?” “A lavurèn mèi, sgnaur padròn, s’a cantèn un po’”. Al padrone conveniva continuare il giro e lasciar perdere.
Si alzavano la mattina presto, molto presto, le operaie agricole e le mondine tra al lómm e al scur o al bur adiritura per preparare un po’ ed duzìna per chi rimaneva a casa: dau taiadlin, una partidina ed parpadlén o ed mundlén di sfoglia tirata a mano, impastata anche solo con l’acqua perché l’uovo poteva essere un lusso, per cuocere un umidén ed ranuc ciapè int’la riséra e per far bollire du góbbi ed cunsérva cumprè int’al scartuzén, che serviva a dare un po’ di sapore al tutto. Il ragù con la carne, in certi anni, era anche quello un lusso. Prima di partire per il lavoro, veniva messa fuori dalla porta di casa, vicino al muro, una catinella piena di acqua da scaldare al sole per un bagno tiepido e rilassante al ritorno, indispensabile nei periodi in cui si lavorava alla macchina da bàtar al grèn e si ritornava a casa cun i conotèt cambié dal tótt, a causa della densa polvere e dal låcc che avevi respirato e ti aveva avvolto per una giornata intera. Ai bambini, a casa, era stato affidato l’incarico di controllare ogni tanto che nell’acqua non finissero, e non rimanessero, moscerini, ragni, formiche o addirittura mosche. Purtroppo, il compito, siccome era troppo bello giocare, non veniva svolto sempre con l’attenzione necessaria e allora, alla sera, al vuléva quèlca scaplòta o soquènti zavatè. La “mangiolica”, per tante famiglie era un incubo, specialmente d’inverno, quando non si lavorava e si era costretti a tirar fuori al librått da sgnèr confidando nella disponibilità dei bottegai. C’era però chi si vergognava a fare segnare il debito e allora preferiva mangiare con i suoi come poteva: dla zivålla, di radisén o un påss gat o du ciapè int’la val.
In certe famiglie, il riso, che si poteva spigolare e fare pilare da qualcuno in modo rudimentale, ma efficace, oppure che si possedeva nella quantità di un chilo al giorno per diritto sindacale acquisito dopo anni di lotte, diventava d’inverno il re della tavola: un giorno in bianco o imbraghè cun l’aqua, un altro con un po’ di conserva (póca, a m’arcmènd, parché la gòsta), un altro con un mezzo uovo sbattuto per otto o nove persone, un altro ancora sótt cun un cichinén ed butir fat in chè con la panna del latte bollito; il più atteso era il giorno del riso nel latte o con le castagne secche, ma era un giorno da signori. E dopo? Gninti!... era grossa se c’era una mezza mela o un grapadén d’ua, magari stachè da una bindèna in un chèmp, d’arpiat. In zò, quando ancora si mangiava sull’argine cun al scartuzén purtè da chè dovevi provare di convivere con le formiche che entravano numerose nelle sporte di giunco o ed pavìra, lasciate sull’argine stesso appese ai pedali della bicicletta rovesciata e coperta con un ombrello verde, ampio (l’umbrela dla val, chi l’aveva, altrimenti at sc-iupéva i cupartón e t’at cusìv al zarvèl). Si cercava di mettere in atto tott’il varcmènz pussebil, ma contava il giusto. Peggio era quando circolavano sul pane o sulla fetta di mortadella i furmigón che s’at fóss mai capité ed magnèn on, t’avanziv sazi fén a sira. Il massimo era quando si poteva tucèr un pezzetto di pane su una fettina ed panzåtta inspriché, abbrustolita a un fuoco improvvisato sull’argine. Un mangiare acsé trést ti manteneva la linea ma ti mandava anche al pavaiòn par la diblìsia: era complice di questo anche il sole brusènt d’estate, dal quale non sempre ti poteva proteggere abbastanza il fazzolettone bianco, la “capana”, che ognuna si era preparata infilando un pezzo di cartone tra i due lembi, come una visiera. A poco a poco, negli anni furono riconosciuti, dopo lotte sindacali non indifferenti, diversi diritti che migliorarono le condizioni di vita delle mondine e delle operaie agricole: non succedeva assolutamente più, per esempio, quello che accadde, negli ultimi anni ’20, alla Renata che, ritornando dal lavoro, arrivò appena in tempo ad appoggiare la bicicletta e la zappa al muro della casa e a correre all’ospedale dove, dopo nemmeno un’ora, il bambino era già nato.
Negli anni ’60, l’Ufficio di collocamento organizzava il lavoro presso aziende agricole che richiedevano operai. Erano tenute, naturalmente, a rispettare tutti i diritti conquistati: dovevano assicurare anche il mangiare del mezzogiorno e il bere durante il lavoro. Un’estate, durante la stagione degli “zucchetti” ch’i rinfråscan dimondi, uno degli operai, che diceva sempre la verità scherzando, arrivò una mattina al lavoro, in pieno agosto, con il cappotto, il cappello invernale, un maglione e i calzoni di lana. Bèn csa fèt cl’è un chèld ch’as grònda. Oi, a forza ed magnèr sti zuchétt tott i santé dé, a un son tènt rinfrischè ch’a iò un frådd ch’a ni dur. A qué, cun tótt sti zuctén a sc-iapa ènc una polmonite dòppia! Auf chichina! Il giorno dopo, comparve per il pranzo un’insalata di pomodori insieme al companatico: tutti ringraziarono il rivoluzionario pacifico, che aveva raggiunto lo scopo, a beneficio di tutti. Il bere veniva distribuito dalla vinatìra, che era un’operaia del branco, spesso non in grado di sopportare, per la giovanissima età o per problemi di salute, i ritmi molto faticosi di certi lavori. Il bicchiere era unico perché ci si faceva sempre èd nått delle compagne come se si fosse nella propria famiglia. Non era certo colpa della vinatìra se, a volte, il vino al pareva un po’ asè, o se la quantità int’ la zócca scarseggiava. Ció, Eva, tè t’vè sempar a Måssa, dìsni ancòrra in Cisa “dar da bere agli assetati?” Sé, sé, sèmpar, fu la risposta all’amica che si era accorta che la quantità del vino tendeva spesso a calare. I giorni seguenti il livello int’la zócca l’ira un po’ pió da cristièn: qualcuno di quelli che contavano aveva udito.
La storia delle nostre bisnonne, delle nostre nonne, delle nostre mamme, la storia delle nostre radici è questa. Siamo orgogliosi che anche il Presidente della Repubblica, al Quirinale, il 1° Maggio, abbia potuto ascoltarla direttamente dalle nostre mondine attraverso le loro “cante”, “i trón”, che raccontano le vicende, i sacrifici di una vita grama, il coraggio e la tenacia di tante generazioni per ottenere ed assicurare a noi tutti condizioni migliori, che rispettino in primo luogo la dignità dovuta ad ogni essere umano.
Giuliana Grandi
Testo tratto da "Lavoriamo meglio se cantiamo" in "Brodo di serpe - Miscellanea di cose medicinesi", Associazione Pro Loco Medicina, n. 10, dicembre 2012.