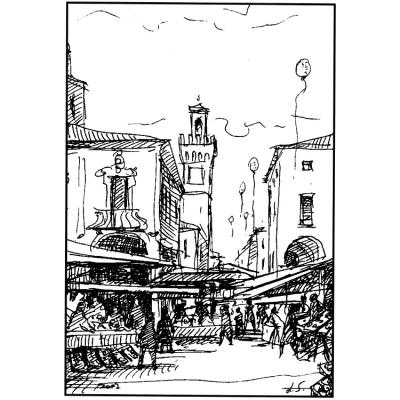Schede
Sono stati numerosi gli eventi promossi a Medicina nel 2007 per ricordare e valorizzare il mercato settimanale del giovedì che compiva ufficialmente 500 anni di vita. Più che le iniziative attivate dalla pubblica amministrazione, che hanno coinvolto soprattutto le categorie dei commercianti in riflessioni e proposte operative riguardanti il futuro del settore, a “Brodo di Serpe” spetta – come da sua tradizione – dedicare uno spazio a quanto di storia e tradizione è stato presentato all’attenzione dei cittadini nella mostra di settembre al Carmine diventata, da tempo, occasione privilegiata per approfondire e comunicare aspetti salienti del nostro patrimonio. Nel 2007 era d’obbligo dedicare attenzione ai 500 anni del mercato del giovedì.
I protagonisti dell’istituzione del mercato di Medicina sono in sostanza due: gli “Uomini” di Medicina - vale a dire gli amministratori della Comunità – e papa Giulio II, Giuliano della Rovere; e il contesto storico in cui ciò avviene è quanto mai critico per il nostro territorio, riguardo alle condizioni economiche generali, e nello stesso tempo di determinante importanza per la svolta politica impressa dall’energico e battagliero papa allo Stato della Chiesa in generale e alla città di Bologna in modo tutto particolare. Tutta la Romagna, negli ultimi anni di Alessandro VI Borgia, era stata oggetto dell’azione intrapresa dal figlio Cesare Borgia, nominato dal papa duca di Romagna, per recuperare alla Chiesa le città governate da signorie che solo nominalmente riconoscevano la sovranità della Santa Sede, di fatto agivano con pieni poteri e spesso in lotta tra loro. Medicina e il suo territorio sono teatro di pesanti scontri tra le truppe del duca Cesare Borgia e dei Bentivoglio, divenuti anch’essi signori di fatto a Bologna; a Villa Fontana si accampano armati di Cesare, che stenta ad affrontare il signore di Bologna a motivo dei suoi potenti alleati. La popolazione locale è comunque stremata dalle scorrerie degli armati e intorno avanzano miseria e fame. Scomparso Alessandro VI nel 1503, dopo un fulmineo pontificato di Pio III, viene eletto papa Giuliano della Rovere, da sempre nemico dei Borgia, col nome di Giulio II. Uscito di scena il duca Valentino, il nuovo sovrano pontefice riprende la politica di riconquistare alla Chiesa la Romagna e soprattutto Bologna. Dopo un lungo e tortuoso percorso attraverso Umbria, Marche e Romagna, alla testa di un’armata e con un seguito di dignitari, Giulio II l’11 novembre 1506 entra senza colpo ferire nella Bologna già abbandonata dai Bentivoglio. Subito il papa emette una serie di provvedimenti a beneficio del popolo, porta il “senato” bolognese da 16 a 40 membri e ripristina prerogative ed esenzioni a diverse Comunità del contado. “I nostri Rappresentanti Municipali – scrive Giuseppe Simoni – non lasciarono sfuggire questa favorevole occasione per liberarsi dalla servitù bolognese e per assicurare di nuovo gli’interessi materiali alla loro patria… il nostro Comune avanzò un memoriale alla magnanimità del Sovrano Pontefice, pregandolo a volergli riconfermare i suoi privilegi… la supplica fu accolta favorevolmente…”. Con un primo breve il papa ripristina per Medicina tutte le disposizioni che la sottraggono alle imposizioni fiscali del governo bolognese; con un secondo breve, del 24 febbraio, il pontefice concede ai medicinesi di tenere “entro al Castello” mercato ogni giovedì riconfermando “tutti i privilegi acquisiti”. La politica di favorire le comunità periferiche allo scopo di controllare l’espansione delle città si ripete ancora una volta a vantaggio di Medicina: ciò era avvenuto nel 1155 con il diploma di Federico Barbarossa, nel 1507 si ripropone per volontà di Giulio II. Il nuovo assetto politico consentirà al territorio medicinese due secoli e mezzo di stabilità e di sviluppo economico, comunitario e culturale che conferiranno a Medicina il carattere e l’aspetto che ancora oggi presenta. Il secolare mercato fa parte integrante di questo percorso di crescita.
Nelle varie sezioni della mostra, oltre ai documenti originali, erano proposti richiami ad episodi storici di quel particolare snodo storico e profili dei principali personaggi attivi in quel complesso scenario. Oltre ad un accenno ai mercati e alle fiere una testimonianza di immediato interesse era dedicata alle immagini, storiche ed attuali, della vita che anima il mercato. Foto di diversi periodi mostrano l’evolvere della conformazione, della tipologia del mercato di Medicina e soprattutto fissano efficacemente le figure che ne costituiscono il nerbo: gli ambulanti, i commercianti, i frequentatori e soprattutto le donne, vere protagoniste della vitalità di ogni mercato. (Luigi Samoggia - Testo tratto da "IL 5º CENTENARIO DEL MERCATO IN MOSTRA" in "Brodo di serpe - Miscellanea di cose medicinesi", Associazione Pro Loco Medicina, n. 5, dicembre 2007).
Nota fonetica: Le vocali lunghe hanno l’accento circonflesso: å corrisponde ad “a” che tende verso “o” molto aperto come in Bulågna o dmånga nel medicinese del Borgo; č corrisponde a “c” dolce italiana come in bacio; ğ corrisponde a “g” dolce italiana come in gita. – Òccia, cum ti tótta tirata, t’un pèr la Madòna dal Gindlén, t’è prinfén la gulèna! – Bèn soncamé, a sòn gnu a Migina al marchè. Ènca té però a vådd t’an i mia da mènc. Questi scambi di gentilezze si potevano udire tra i banchetti del mercato il giovedì o la domenica a Medicina perché in quei giorni, per quell’occasione, ci si vestiva di nuovo, indossando gli abiti migliori. Il mercato era infatti sentito ogni volta come un avvenimento festoso, spesso atteso con un po’ di trepidazione: dagli uomini perché in piazza si poteva iniziare o concludere un affare, magari con l’aiuto di qualche sensale che ti attendeva proprio là davènti al Cafè Grènd o ala butaiga da barbir dal Munarén; dalle ragazze e dalle madri di famiglia perché era giunto il momento, spesso sospirato da tempo e lungamente atteso, di fare un acquisto che aveva comportato rinunce di diverso genere al fine di accumulare i soldi necessari. Le donne che vivevano in campagna, quènd i andévan a livér i gli óv da purtèr a l’arzdàura, ne tenevano qualcuna per sé e, al momento in cui le vendevano al mercato dei polli, unitamente a quelle della famiglia, riuscivano a mettere da parte quèlch baiuchén; per le donne del paese, invece, era più facile fare un po’ di cresta sulla spesa quotidiana in modo da riuscire a cavès quèlca vóia ènch s’l’ira da póc. Erano sempre voglie che dovevano essere contenute entro certi limiti e non eccedere mai anche perché a j’ira sèmpar póc slavag con i sotterfugi messi in atto pr’avanzès chi du o trî góbbi. Il mercato dei polli (così lo chiamavamo noi medicinesi) si svolgeva un tempo int la piazzåtta dla funtèna davanti al palaz èd Lambèc in via Mazzini, fino a che, demolito al cinema èd Ciaparóni (che, veramente, a un certo momento, crollò, parché l’ira un baracòn èd lògn) si trasferì nel piazzale attiguo alla Chiesa del Crocifisso. Erano soprattutto le donne, e spesso i gli arzdàuri ståssi che portavano dalla campagna le uova, i polli, i pulcini, i conigli, le faraone, le anatre (ènch quålli mótti), per Natale in particolare i gapón, allevati da loro e che vendevano ai pollivendoli i quali la mattina, prestissimo anche d’inverno, si apprestavano ad occupare lo spazio riservato nella piazzetta. La Gibèla, la Pramsèna, la Pandurina, la Graziella, Felizina, la Rina e la Gianna ed Maròc erano le figure più note della vendita del pollame a Medicina accanto agli uomini come i Pramsèn, i Mirèna, i Zanelli. Erano donne intraprendenti le medicinesi, decisamente autonome nella personalità, autentiche, libere nell’espressione del proprio pensiero che era quello delle persone oneste, coraggiose, pragmatiche, sicure nel proprio agire, creative nel loro lavoro con il quale contribuivano in maniera molto sensibile e significativa a tirare avanti la famiglia, allora sempre numerosa e molto bisognosa di sostegno. Erano lavoratrici instancabili e digl’inzgnadàuri insuperabili. Làur bèn ch’i savévan badèr ala chènta! Per recarsi al mercato dei polli a vendere ai commercianti il frutto delle loro quotidiane fatiche, le donne medicinesi della campagna partivano da casa in bicicletta quando ancora era buio e anche quando la neve era alta: venivano da tutte le parti del Comune. Arrivate a Medicina, portavano la bicicletta dai meccanici, che facevano anche servizio di deposito, ad esempio da Méntore e da Santén in via Mazzini, proprio di fronte alla piazzetta del mercato dei polli, oppure da Lino che si trovava un po’ più avanti quèsi al’inèzi dla strè èd mèz int la piazzåtta dla Cisa di fré. D’inverno, quando giungevano al deposito, erano completamente inciudè dal freddo gelido, e, a volte, dovevano essere aiutate a scendere dalla bicicletta e condotte subito, per scaldarsi un po’, vicino al camino acceso della cucina, che si trovava nel retro del locale di lavoro. Quando al tiréva sarnèr arrivavano addirittura sènza fié tènt ch’a j vréva dla bèla e dla bóna a fèli arvgnir un pó. Spesso, prima che il mercato prendesse il via e funzionasse a pieno ritmo, si recavano in chiesa per la prima Messa, portando con sè le ceste piene di pulcini appena nati, a volte talmente pigiati perché si tenessero caldi uno con l’altro, che quèlcadón l’arbuiéva e al tiréva i ùltum. In chiesa poteva accadere che, nel raccolto silenzio generale, si udissero dei vivaci pìo-pìo provenire dalle ceste appoggiate a terra o su qualche panca libera. La voce imperiosa di Monsignor Vancini ammoniva dall’altare: I pisén fòra! I pisén fòra! Per cercare di troncare subito cal sgumbèi irriverente, le malcapitate raccoglievano immediatamente il tutto e uscivano in fretta per lasciare l’incriminata cesta nell’abitazione vicina di qualche conoscente e ritornare poi in chiesa per seguire la Messa fino al termine.
Quando, dopo le pratiche devozionali, arrivavano nella piazzetta del mercato, si trovavano il più delle volte a tu per tu con qualche massaia del paese che avrebbe voluto acquistare da loro direttamente uova o polli per il consumo quotidiano della famiglia in modo da evitare il passaggio al commerciante, che avrebbe comportato, ovviamente, una lievitazione del prezzo. Gî pur èd nò, a sèn zènt séria nuétar, miga dil badòia. E pò, quåst l’é al nòstar médar, an psèn mia pérdi i pularù! A volte arrivava qualche contadino con le pelli delle faine che gli era capitato di catturare nel fienile o attorno al pollaio; dopo averle essiccate e riempite di paglia, le portava al mercato per un piccolo commercio secondario in quanto potevano servire, come le pelli di coniglio, ad esempio, per fare dei rudimentali manicotti da infilare nelle manopole dei manubri delle biciclette allo scopo di riparare le mani dal grèn strèzz dl’invéran ch’at carpéva tótt il dida oppure per confezionare, da parte delle donne di casa, qualche collo di pelo che potesse attutire i rigori del freddo quènd al géva pròpi da bòn e at zléva tótt i paramìnt intéran. La Maghina, che con la sua carriola era solita vendere per il paese la taurta mingóna, i luén e, bèle còti, il patèn americhèn, la zócca, la zivòlla e il mèil, giungeva a volte nella zona e chi le passava vicino si sentiva dire: Ai ò dau o trèi sfilz èd ranùc, bèle pulì: in vriv? Ièn dil cosc ch’i pèran di bua! Il mercato dla cuntrè èd mèz e dla piaza aveva inizio un po’ più tardi: era il mercato degli scampoli, della stoffa in pezza, della maglieria, della lana. Ci si fermava ai vari banchetti per guardare, chiedere, toccare la merce per capire se era di qualità, per fare con il pensiero i conti nella propria e donne si incominciava a contrattare il prezzo. Se chi vendeva chiedeva cento, la risposta era spesso: Mé an v’in dag brisa piò èd stentazénq, se no a m’avèi; si cercava anche di denigrare il prodotto: L’an é pò mia ròba tènta bóna, in clètar bancåt alé la gòsta mènc e pò dòp l’é èd qualitè miàura! Al tentativo dell’ambulante di non cedere, seguiva, da parte della compratrice, la mossa che risultava quasi sempre vincente: voltava le spalle e cominciava ad andarsene. Si verificava allora il cedimento: Andèn parché a si vó, a v’al dag par nuvènta ma, se l’acquirente era risoluta, riusciva a raggiungere pienamente lo scopo che si era prefissa: Gnìn a qué andì lè, parché a si una mi cliènta, a m’in darì stentazénq, mó a v’asicùr ch’a i armèt. Incù a fag di afèri dimóndi trèst, a féva piò óvra a stèr a lèt. Così si concludeva l’accordo. Era questo lo stesso modo di fare degli uomini che davènti al cafè grènd e ala butaiga dal Munarén trattavano gli affari: l’ira tótt un tirér da una parte e dall’altra. Se si incominciava il giro del mercato partendo dalla Cisa di fré, si trovavano Gigiòta e Tugnina èd Sandrén con gli scampoli, poi via via s’incontravano la Demétria con la lana, Imarìna (cun ch’il bèli mai èd såtta grisi e bartìni e ch’il mudènt par i òman lónghi fén ai pi, gròsi e falpè ch’al pséva ènch tirér la bura) Emma ed Piunzina con le maglie e di bi fular, la Lea Monti cun la biancaria, Zilèsta e l’Armida con la stoffa, Bertino, la Césera e Iose con la maglieria di una certa qualità, e la Garantissi che vendeva il nan (che erano le cuscine per i neonati), orlate di pizzo fatto a mano, tótti insaldì, e con richiami di una certa finezza soprattutto in quelle per le cerimonie del Battesimo. Al batèisum l’a l’è cumprè dala Garantissi e si intendeva, oltre alla nana, la scufîna, i scarfarutén da mettere nei piedini, i manuplén che avevano solo il pollice da infilare, perché così era molto più facile farli indossare ai bambini appena nati che, spesso però, se li portavano alla bocca e înspudacévan tótt riuscendo anche a sfilarseli e a renderli del tutto inservibili dopo la cerimonia. Anche dalla Regitlìna, che i primi tempi aveva il banchetto dirimpetto al negozio èd Torresàni, si acquistavano i pizzi (per esempio il macramé che negli abiti e nelle camicette femminili era segno di distinzione) ma da lei si potevano trovare anche i calztén fat a mèn da l’Evarista, la mèdra èd Maróc. Erano calzettini che duravano una vita, èd lèna bóna o anche di quella da pastàur che, ènch s’la rusghéva un pó, an si féva brisa chès perché allora a s’ira póc sufèstic; duravano molto perché la parte più deperibile, la suoletta, si rifaceva con i ferri, a mano, ogni volta che comparivano buchi tali da non poterli più rammendare: se i buchi erano piccoli, a si déva du o trî puntlinén e vi ch’a s’andéva.
A fare la sulåtta le mamme e le nonne insegnavano alle bambine fin dai sette-otto anni. T’è da imparèr a fèr la sulåtta, ètarché stèr a pérdar dal tèmp a zuglinér; era un ritornello che le adolescenti si sentivano spesso ripetere e che tenevano in seria considerazione perché alla prima affermazione veniva spesso aggiunto cum farèt a truvèr maré s’t’an sè gnènc fèr la sulåtta! Non si poteva non ubbidire, rischiando di rimanere zitella e di diventare poi con gli anni una ragaza antiga che inción l’avéva vru. Bisognava anche imparare ad essere svelte altrimenti ci si sentiva dire: Ció ti un bèl indòvs, té ti mór in våtta a cla sulåtta alé. Nei banchetti come quello della Regitlìna si trovava anche il cotone per cucire: i ruchèt, il starlìn, al cutòn dil trei C, ch’l’ira dimóndi bòn, al rivadén che serviva per cucire al spinòn, una stoffa da buon comando con la quale si facevano i pantaloni da lavoro per gli uomini; si potevano comprare i fazzoletti da naso, grandi, di stoffa un po’ consistente, róss e zal, che si legavano anche attorno al collo per asciugare il sudore durante il lavoro, e al sfragòt che, cucito negli orli, rendeva più resistente, ad esempio, il fondo dei pantaloni da uomo. Cum as dìsal in italiano al sfragòt? Chiese mia sorella, allora bambina, a mia zia Eva che la mandava a comprarne due metri al mercato. Ció mé an al sò brisa, a Migina a gèn acsé, té dî mò cun tvu. Poiché la bambina non si decideva ad uscire, chi era in casa cercò di trovare un’espressione italiana: T’è da dir quella strisciolina che si mette per non far ‘sprasolare’ i bragón di òman. Tum da mèl e metm’a piz, la situazione diventava sempre più ingarbugliata. Alla fine tutti i tentativi di traduzione italiana terminarono con un’affermazione perentoria: Fa mò póc arabìr: dî sfragòt e fa póchi smani. Non si è mai saputo che cosa fu detto alla venditrice, ma l’impresa, per fortuna, fu portata a termine felicemente anche perché al mercato medicinese non c’era bisogno di tradurre in italiano le nostre espressioni dialettali. Un tócco un po’ cittadino si notava invece nel cartello issato sul banchetto della stoffa della Regalata: “La Regalata è qua con tutte le novità!”. Un tempo, per fare gli acquisti, le nostre venditrici medicinesi si recavano a Bologna con la littorina della Veneta o, addirittura in bicicletta, che lasciavano in un stalagt al capolinea del tram con il quale raggiungevano poi il centro. Si servivano di negozi anche di un certo nome “Schiavio-Stoppani” in via Orefici, “Guidotti” in via Riva Reno e, per gli scampoli, era noto un venditore all’ingrosso di via Irnerio, vicino al Palazzo della Zanichelli. Non eravamo poi a Medicina campagnoli del tutto! Più tardi, alle biciclette si attaccò il mosquito e, a poco a poco, ci si motorizzò: le nostre donne non erano delle provinciali dall’orizzonte limitato, ma seguivano il progresso e non le fermava nessuno. Accadeva anche che, negli anni in cui la miséria la féva i cinén si procedesse a scambi in natura: si poteva cedere, ad esempio, qualche scampolo per una certa quantità di fagioli che poi venivano portati nella bottega di alimentari èd Tàlia, che ne preparava la cottura stando bene attenta a brisa armisdèr i fasù da l’oc cun chiétar.
Nei giorni di mercato molti negozi della via centrale facevano l’esposizione all’esterno, sotto il portico: la Bentàuna metteva in mostra le pantofole di panno e tante altre cose, perché nella sua bottega a j’ira d’incósa compreso al canfén pr’il lumir che spargeva in tutto il locale interno un odore caratteristico di cui erano impregnati parfén i caracatù, il scarpìn e i burdigón èd sughi miclèzia che ai bambini piacevano tanto ènch si savévan èd petròli; Luziòta, la surèla èd Ptròni e Gnazi dla ferraménta, oltre al póvv e ai bambùz èd stòfa metteva sotto il portico tutti gli accessori pr’il lumir, il granè fatte a mano dagli uomini della nostra zona, i prit e il sór per mettere d’inverno al fug a lèt in modo che, quando ci si infilava sotto le lenzuola, l’ira un caldén ch’at paréva al paradis; Frabòn, al Grussèsta, esponeva la sua stoffa e, nei tempi passati, anche i spulvrén e il caparèl, belle, ampie e lunghe che i bén i sguazévan un mònd a stèi såtta quando uscivano d’inverno con i padri o con i nonni, che le indossavano; fuori dal negozio dla Casåtta, Funsòn, in pìa o a sédar, controllava con occhio molto vigile che nessun passante creasse danno alla merce sui banchi o appesa a i uccètt dal pórdg (l’Emma, sua sorella, ch’l’ira un pó piò asìva cun la zènt, rimaneva invece all’interno a vendere dietro al bancone tr’al lómm e al scur perché in quel negozio, lungo e stretto, senza finestre, entrava sempre poca luce); Carlòta e Marì èd Bentén all’esterno delle loro botteghe, che erano su portici diversi, disponevano, tra l’altro, tótti il guarniziòn pr’il ftin, e i pèzz, e Maria soprattutto, (che coglieva spesso l’occasione dalle parole delle compratrici per intonare il motivo di una canzone) i bottoni, genere nel quale era insuperabile: ne aveva di tutte le fogge e di tutti i materiali, compresa la madreperla, che era il massimo che si potesse desiderare di avere in un vestito. Int la ftina e giaca èd tusòr èd sèida l’a j è mès prinfén i ptón èd madrepérla. Che milàurda! I negozianti di alimentari, come Dante e l’Ines o, per esempio, la Bruna èd Tatà, ci tenevano a far vedere a chi passava che avevano in vendita del buon baccalà, grosso, turgido, ancora immerso nell’acqua di una catinella. Quando ci si voleva vestire da caval intìr, da có e våtta, si andava a fare gli acquisti dai venditori della stoffa in pezza: da Margarètta, dai Sabión, dala Mantvèna, dai Nigrón, da Galòt, da Frabòn al Grussèsta e spesso ci si faceva accompagnare per avere consigli sul tipo di stoffa e sull’assortimento dei colori, dai sarti, che erano dei veri professionisti. Al sèt ch’l’è cumprè la stòfa par fès una ftina èd séta pura! Adès la vrè bèn fèr la sgaligìna; l’è pò un grèn burgòz listòss! Ció chicalè l’é cumprè un Zégna par su maré, e, l’ètr’an, un Marzotto, però l’a iè tólt tótt é du a tèmp perché accadeva che non si avessero subito i soldi per pagare e non si ascoltassero i vecchi della famiglia che ammonivano: Par di caprèzzi, la ròba l’as còmpra sàul quènd a s’è i baiùc! Chi voleva spianèr alla domenica cun dau scarpin cum vè se le faceva fare a mano dai nostri bravi calzolai medicinesi. Ricordo di avere avuto due scarpe confezionate da Galinér ch’îran du bilén éd zòcar. La borsa acquistata da Mimmi såtta al’arlói era il tocco finale, la nota di signorilità ch’l’at féva pròpi stimér cmé an so cósa. Le ragazze che dovevano sposarsi si facevano ricamare il corredo dall’Evelina; si recavano allora, insieme alle madri, ad acquistare la stoffa, spesso di seta pura, i pizzi dei più pregiati, la passamaneria di un certo valore, il crèpe di raso o il tulle, dai venditori di maggior prestigio. Farsi fare il corredo dall’Evelina significava essere dotate di una certa finezza di gusto, ma voleva anche dire di essere riuscite a mettere da parte una sommetta a costo di rinunce non indifferenti: Va mò lè, as marìda una vólta sàul int la vètta! In tempi un po’ più remoti, le donne dovevano accontentarsi per l’abbigliamento quotidiano d’un grimbalunzén èd tibetina che era una stoffa ch’la gustéva al giòst. Si poteva però ricevere qualche complimento lo stesso quando lo si indossava: Mó guèrda che bèl sprucainén se si era giovani, oppure Che bèla spuslòta se l’età era un po’ più avanzata.
Nei primissimi anni ’50, comparve al mercato la vendita che subito fu denominata “l’America stracci” o semplicemente “l’America”. Pullo e la Bibi ién gnu a chè sta stmèna da Prato cun dil bal èd ròba dl’America, bellèssima. Il tam-tam si spargeva nel Borgo rapidamente e le “habitué” si recavano subito nella strada della Torre dell’Orologio dove si trovavano i banchetti con la merce, cercando di arrivare prima di altre per accaparrarsi i pezzi migliori. Come quello di Pullo con la sorella Maria, della Bibi e dla Trincarina, anche i banchetti della Libera, èd Toni e la Lucia, dl’Alda èd Pulònia, dl’Ada èd Ricco erano sempre attorniati da numerose donne che rovistavano nell’ammasso degli indumenti, delle giacche, dei “paletò”, di prussianén e di paramidò stile americano, dei colli di pelliccia, cercando ciò che poteva loro servire: a volte si trovava quèlch sblìtter da póc ma l’occhio delle compratrici era esercitatissimo e lo scarto avveniva immediatamente. Quåll alé l’é un guacén, mèttal pur via! Pullo era simpatico, aperto, sincero nel modo di esprimersi, però aveva le sue preferenze: non gli andavano a genio certe sue clienti che considerava pretenziose e stancanti. - Bèn Bruno (questo era il suo nome) parché èt dèt a chicalè t’an è brisa quåll ch’l’a tè dmandè? - Mó parché l’é pèisa cmé l’èibi di bua; la stè a qué digli aur a guardèr, a tuchèr, a tirér in våtta al prézi e pò an i vè mai bèn gninti. Ch’l’as arèngia! Per chi sapeva fare a cucire gli abiti, l’America fu per tanto tempo una gran pacchia: si spendeva poco e la stoffa era quasi sempre di qualità. A volte, rovistando, ti capitavano tra le mani degli abiti da sera èd sfolgorènt, èd crèpe, èd taftè, d’organdis con nastri di tulle di vari colori o dei corpetti tótt pén èd piltrén traluchìnt che ti facevano venire in mente le belle scene dei films americani, allora frequentissimi nelle programmazioni delle sale cinematografiche italiane e, da noi, del cinno èd Bini dove ogni domenica facevamo la fila per entrare per poi rimanere spesso in piedi per tutta la rappresentazione. Mi piaceva moltissimo, quando ero bambina, andare al mercato con mia madre tanto più che credevo, a tre o quattro anni (e ne ero fermamente convinta), che mia madre, casalinga, guadagnasse dei soldi quando, dopo aver scelto che cosa comprare, allungava al venditore una carta moneta e ne riceveva in cambio più di una, compresi diversi spiccioli. Erano tempi in cui noi bambini a îran un pó indrìa (brisa come qui d’incùa ch’i capèssan incósa in du e du quàtar). Gli adulti poi si divertivano ad ascoltare le nostre ingenuità e ce le facevano ripetere: Duv guadàgnla i baiùc tu mèdra? Al marchè, e loro erano felici di avere dei bambini simpatici. Nel giro che facevamo al mercato, gli acquisti della frutta e della verdura avvenivano di solito al termine: nella via Fornasini trovavamo l’Ersilia con il suo lungo carriolo di legno, verde, pieno di prodotti freschi e genuini del suo vasto orto, posto all’entrata del paese. Tu mò che parché ti bèl at dag du prugnén, o vut un garavlén d’ua macaràuna? E l’ua frèvla at piésla?: erano le espressioni che rivolgeva sempre ai bambini che accompagnavano le madri a fare la spesa perché l’Ersilia era di modi simpatici, affettuosi e possedeva tratti di vera generosità. Rumèna cun su fiól Camèl, la Gigia èd Mòlla, la Mariòta, la Bumbardina, la Pizpulina (più tardi, divenne una figura molto popolare Melèndar) erano le altre venditrici del mercato di frutta e verdura e sui loro banchi si trovavano anche i patarlèn, i lazarén, il sórbal, il nèspal, il zìzal, il mèil granè, frutti oggi dimenticati ma che a noi bambini piacevano tanto.
Mio padre raccontava che, ai suoi tempi, era una gran gioia per i ragazzini comperare, i giorni di mercato, “un giardinetto” ch’l’ira un scartuzén èd chèrta zala, fatto a imbuto, con dentro una caròta (che era poi una carruba), du brustulli americhèn, un fig sòc cun la mèndla in mèz, du o trî pgnù, una nus e dau castagn, èd nómmar! Era un’invenzione tutta medicinese. Quando si andava la domenica alla Messa delle 10, i bambini partivano da casa un bel po’ prima per fermarsi vicino alla fontana del centro ad ascoltare Marino Piazza, il cantastorie, che possedeva l’arte di avvincere piccoli e grandi con i suoi racconti in zirudèla. Li rappresentava visivamente con disegni da lui preparati su una striscia di carta che appiccicava al cappello, un po’ rigido e non bene calcato in testa, in modo che, con opportuni movimenti del capo, la striscia scorresse lasciando vedere le scene disegnate del racconto. Ogni tanto un intermezzo rendeva il tutto molto allegro: con la fisarmonica e a volte con il clarinetto veniva suonata la mazurca della “Migliavacca” che piaceva immensamente a tutti e che era, oltre al zirudèl, il motivo per cui il pubblico si addensava attorno a Marino Piazza il cui scopo era poi di vendere lamette, rasoi, pennelli e sapone per la barba, creme dopo barba e certi aggeggi ben congegnati per la cosmesi maschile, come Biavati in anni precedenti (Biavèti lo chiamavano i medicinesi). In prima fila si accalcavano sempre i bambini, ch’a j vréva dla bèla e dla bóna a spingerli indietro per fare posto agli spettatori adulti, i possibili acquirenti. I ragazzini, a poco a poco, se ne andavano e per compensare un po’ la delusione provata, si dirigevano verso il luogo dei banchetti di bilén dla Fiurintina, dla Norma e qualche anno prima, dl’Ulimpia, per comprare un zòcar filé o un giavulòn culurè con i due soldi che erano riusciti ad ottenere dai genitori dopo una zigadîna o con la promessa èd fèr al bravo. Altri, ad esempio, tornavano dalle loro madri che li aspettavano lì vicino, magari dalla piatlèra, che aveva tutta la sua merce, tanta, esposta sul pavimento della piazza, sotto l’occhio vigile della Renata, che l’aiutava nelle vendite, e di cui mio padre diceva sempre: Dil inzgnadàuri cmé la Renata a in vraré ónna par chè! Verso le 12,30, nel paese cominciava la smobilitazione e, dopo non molto, con l’intervento rapido di spazón, come per incanto , si era già pronti, soprattutto la domenica, per il passeggio pomeridiano (al spasso dala Cisa di fré ala piaza) sotto i due portici, in cui ci si divideva spontaneamente seguendo la tradizione medicinese, secondo il censo: i sgnàuri såtta a un pórdg, i cuntadén såtta a cl’ètar. Tutto questo era il mercato di Medicina, festoso, vivace, impregnato dell’anima della nostra gente, che è sempre stata finemente ironica, con uno spiccato senso dell’umorismo, cun póchi smani e gninti cnómm con quel tanto di sorridente distacco dalle cose che le ha permesso, ogni volta, di affrontare le situazioni con animo fermo, profondamente seria nel lavoro, onesta e soprattutto capace di ideali forti e di tenace caparbia nel perseguirli.
Desidero ringraziare per il prezioso racconto dei ricordi: Primo Brini e la moglie Elda, Rina Bragaglia, la maestra Evelina e Carmine Romagnoli, Gino Selleri e la moglie Liliana, Attilio Trombetti, Gina Pasquali, Leda e Danilo Palmirani, Lidia Pedretti, e Maria Bertolini, che è stata per anni una venditrice nel mercato di Medicina. Un ringraziamento anche a Mauro Cappellari per il simpatico scambio di ricordi che, sotto i portici medicinesi, ci accade di fare frequentemente, con vicendevole piacere, sui modi di dire dei nostri vecchi. (Giuliana Grandi - Testo tratto da "IL MERCATO DI MEDICINA" in "Brodo di serpe - Miscellanea di cose medicinesi", Associazione Pro Loco Medicina, n. 5, dicembre 2007).