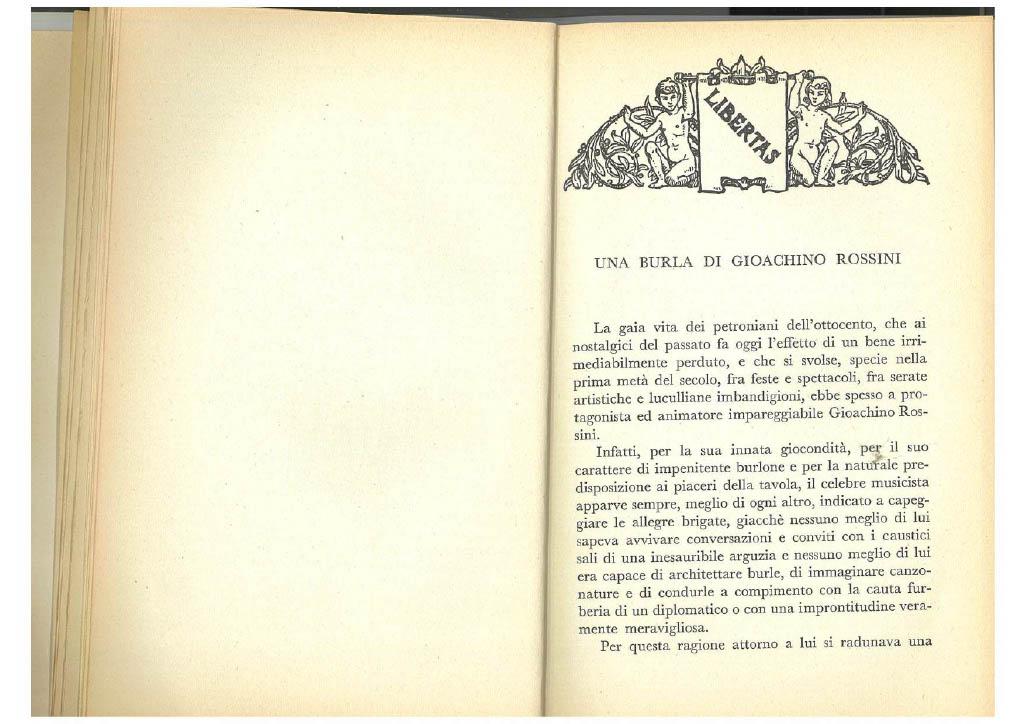Schede
Verso la fine di gennaio del 1825, un giornaletto settimanale bolognese intitolato: Notizie teatrali bibliografiche e urbane ossia il Caffè di Petronio, fondato e diretto dall'avvocato Pietro Brighenti, dava notizie ai suoi lettori delle recite che la comica compagnia Meraviglia e Belloni svolgeva al teatro del Corso nella tradizionale stagione di carnevale, e notando come a tali recite non mancasse il continuato concorso del pubblico, rendeva omaggio al valore dei singoli artisti ed al loro encomiabile affiatamento, ma esprimeva il desiderio che il repertorio della Compagnia venisse «ripurgato di non poche stolidissime commedie e drammi e farse, indegne di ricomparire nei teatri, indegnissime di essere offerte a scelti spettatori...».
Pochi giorni dopo lo stesso giornaletto riproduceva dalla Gazzetta di Venezia del 29 gennaio, un articolo di un critico, allora assai noto e stimato: Tomaso Locatelli, contro il repertorio della primaria compagnia Fabbrichesi la quale, giunta nella città della laguna, preceduta da larga rinomanza, non aveva saputo presentare ai veneziani, in tre mesi di permanenza, che due sole commedie del Goldoni e una sola tragedia dell'Alfieri e s'era limitata, per sbarcare il lunario, a sciorinare una serie di «goffaggini» e di «ribalderie» che avrebbero perfino fatto torto al pubblico che le aveva tollerate, se non fossero state sostenute dal valore del celebre Luigi Vestri, in grazia del quale tutto s'era voluto perdonare. All'articolo del Locatelli, faceva seguito una nota in dialetto veneziano del Caffettiere Petronio, il quale parlando dei comici italiani, senza usar troppi riguardi affermava essere necessario «svergognar sta razza de mastini ostinadi a no sortir dal lezo delle rappresentazion senza garbo nè grazia», ed aggiungeva: «I xe somieri che ga la scorza duretta, ma a furia de dir e svituperar costori, se no i se riformerà eli, se riformerà il pubblico che no li vorrà più sentir, e allora i finirà d'ammorbarne dei avanzi della barbarie teatral». E come se ciò non bastasse, nel successivo febbraio, Il Caffé di Petronio ritornava sull'argomento per muovere rimprovero alla compagnia Meraviglia e Belloni, la quale continuava, ad onta di ogni contrario suggerimento, a riprodurre sulla scena certi aborti indigesti che gli ascoltatori accoglievano spesso con sonorissimi fischi. «La Compagnia Meraviglia e Belloni, continuava il giornale, è una delle nostre buone compagnie comiche; ma ella non cessa di essere una truppa di commedianti italiani, fra i quali è sempre un misto di ostinazione, d'ignoranza e di presunzione» Queste parole così aspre e violente, che al giorno d'oggi solleverebbero chi sa mai quale putiferio pro e contro la libertà di giudizio e di opinione, rivelavano allora l'esistenza di una condizione di cose ritenuta ormai insostenibile per la dignità e l'avvenire del nostro teatro drammatico, e d'altra parte attestavano che la marea di volgarità e di mestierantismo rovesciatasi da oltre un quarantennio sulla scena di prosa in Italia, non aveva del tutto sommersi, almeno nei riguardi della critica, il senso dell'arte ed il buon gusto. Ma il pubblico, pur protestando con le disapprovazioni e le fischiate contro le insulsaggini che, senza scrupoli, gli venivano propinate, non mostravasi, a dir vero, del tutto avverso al deprecato andazzo dei palcoscenici, ancora oppressi da quella produzione tanto abbondante quanto antiartistica, che pareva avesse battuto in breccia le manifestazioni dell'arte vera, dell'arte senza fronzoli e senza truccature.
Da tempo ormai, per amore di novità, la commedia goldoniana poteva considerarsi quasi negletta, e le opere dei pochi e valenti epigoni del grande veneziano, come il Giraud, il Nota, il Bon, ispirate a sani concetti di osservazione, di verità e di misura, non erano sufficienti a soddisfare le necessità delle compagnie e le pretese degli spettatori. Sulla scena quindi continuava a signoreggiare indisturbata tutta la bolsa rettorica sentimentale delle commedie lagrimose e dei drammi romanzeschi del Kotzebue, dell'Iffland, del Mercier, del De Gamerra, del Federici e dei loro insoffribili imitatori, e tutta la incongruenza, spesso sciocca e volgare, delle strampalate Azioni spettacolose, a cui davano vita e la mediocrità degli scrittori e l'insipienza e l'ingordigia dei comici. Naturalmente, una così continuata rappresentazione di tutto ciò che v'era di più inverosimile, di più stravagante e morboso, di più lontano, per voluta esagerazione, dalla natura umana e dalla vita, se da un lato solleticava una diffusa tendenza dello spirito dell'epoca, dall'altro contribuiva a corrompere sempre più il gusto del pubblico e a togliergli la possibilità di discernere il vero dal falso e l'arte dal mestiere. Non è da far meraviglia quindi se, nonostante le acerbe rampogne della critica, la gente correva volentieri al teatro e si commoveva ad ascoltare le brodolose elocubrazioni di Bianca e Fernando, di Chiara di Rosenberg, e degli Esiliati in Siberia; se s'appassionava alle immancabili sbottonature dei generali, re e imperatori che spesso concludevano commedie e drammi, e se si divertiva con gli ultimi detriti della commedia dell'arte, seguendo i casi della Nascita di Truffaldino dall'ovo magico o quelli di Matilde regina di Granata, con Arlecchino buffone di corte. Tuttavia gli umori del pubblico, che in ogni tempo e in ogni paese, non diedero mai eccessivo esempio di logica e di coerenza, rispetto agli spettacoli teatrali, non erano, anche in quegli anni, da prendere alla lettera, giacchè la loro facile mutabilità lasciava largo adito alle più curiose sorprese. E infatti, allorchè nell'aprile 1825, l'ottimo attore concittadino Camillo Ferri riapparve al teatro del Corso, non trovò più quella cordiale accoglienza che gli era stata prodigata nell'anno antecedente, e il suo già applaudito repertorio, a cui aveva aggiunto un mostruoso adattamento scenico delle avventure di Robinson Crosuè, stentò, forse anche per colpa dei mediocri interpreti, a cattivarsi le simpatie degli ascoltatori. Anzi l'impressione prodotta dalla compagnia del Ferri, fu in complesso così meschina, che i bolognesi, quasi per spontanea reazione, parvero rinnegare i loro gusti, talvolta discutibili, le loro non sempre degne predilezioni e si volsero in folla a festeggiare la compagnia comica al servizio del Duca di Modena, giunta nel maggio a sostituire la poco fortunata consorella tanto nelle recite diurne all'Arena del Sole, quanto nelle serali al teatro del Corso. Questa compagnia, diretta dalla vecchia ed illustre attrice Gaetana Andolfati, vedova del celebre capocomico modenese Antonio Goldoni, contava fra i suoi componenti artisti di valore come la prima attrice Luigia Bon, il primo attore Luigi Romagnoli, la briosa ed inimitabile servella Rosa Romagnoli, e il brillante Francesco Augusto Bon la cui fama d'artista drammatico era pari a quella da lui goduta come commediografo. Costituita poi con ben definiti e coraggiosi intendimenti, la compagnia rappresentava di proposito molteplici commedie goldoniane, ed accoglieva nel suo repertorio una scelta d'opere sceniche in cui le ragioni dell'arte soverchiavano le preoccupazioni utilitarie. Un tale programma, che pochi anni prima avrebbe potuto condannarla a recitare alle panche, le procurò invece a Bologna il più caldo, il più cordiale consenso e la stagione si svolse felicemente, sia dal punto di vista artistico che da quello finanziario, mentre i giornali tutti esultavano per il lieto evento e Il Caffè di Petronio esclamava: «Ah! valorosissima Compagnia comica Goldoni, non lasciar la magnanima tua impresa... Tu fosti la prima, tu sei ancora l'unica a rimettere in onore la goldoniana commedia. Ogni altra compagnia che venga dopo per emularti, non potrà farlo che imitandoti». Così per una volta tanto, il pubblico e la critica andavano d'accordo.
Ma fra la generale compiacenza, come purtroppo avviene in tutte le cose di questo mondo, v'era qualcuno insoddisfatto, v'era il Vice-Legato, mons. Giovanni Benedetto Folicaldi, che da troppe sere, nella penombra del suo palchetto, s'annoiava mortalmente e doveva spesso schiacciare un sonnellino per giungere più presto alla fine dello spettacolo. Le manifestazioni d'arte sana e serena che avevano luogo sulla scena, parevano insipide al suo palato desideroso di ben altre droghe. Egli doveva avere un'anima romanzesca, e perciò cercava il fantastico e l'avventuroso, o quanto meno i tragici casi atti a produrre intense sensazioni. Il favore del pubblico per quelle che egli riteneva cosette insulse e leggere, gli sembrava un non senso, un traviamento del gusto e perciò, fra uno sbadiglio e l'altro, decise di correre ai ripari, ed una mattina, racconta il Rangone, chiamò nel suo ufficio l'impresario del teatro del Corso e gli disse che le commedie del Goldoni avevano ormai fatto il loro tempo, e che conveniva offrire ai frequentatori del teatro di prosa qualche cosa di più moderno e di più attraente, o qualche dramma, o qualche tragedia come, ad esempio, la Virginia dell'Alfieri. Sorrise l'impresario a sentirsi proporre da Monsignore la tragedia esaltatrice delle virtù repubblicane, ma per necessità di cose, finse di trovar giuste le ragioni da lui addotte, e promise una serie di speciali rappresentazioni di genere drammatico e di genere tragico. Accordatosi quindi con la Direttrice della Compagnia, stabili di mettere in iscena, ad inizio delle nuove recite, il dramma intitolato La mano di sangue, informe zibaldone già rappresentato con fortuna nei teatri petroniani. Intanto la notizia dell'improvviso quanto inopportuno gesto del Vice-Legato spargevasi rapidamente in città e, sollevando infiniti e svariati commenti, trovava il terreno propizio per far nascere il proposito di una pronta ed eloquente risposta. E infatti, come per una tacita intesa, la sera del 19 giugno, ogni ordine di cittadini si recò al teatro del Corso, e non appena il dramma giunse alla sua seconda scena, una generale fischiata risuonò nella sala, mentre tutti gli sguardi volgevansi verso il palchetto di mons. Folicaldi il quale, sorpreso dalla strana serenata eseguita in suo onore, rimaneva un po' interdetto e confuso.
Ma anche dopo il primo e dopo il secondo atto, le manifestazioni ostili si rinnovarono in modo tale, che i comici, per evitare conseguenze spiacevoli, abbandonarono la Mano di sangue al suo destino e conchiusero la serata con una graziosa farsetta che valse a ristabilire la quiete e la serenità. Nelle sere successive poi furono, con soddisfazione di tutti, riprese le commedie goldoniane, e il Vice-Legato, fatto buon viso a cattivo gioco, dovette continuare ad annoiarsi fino all'ultima recita, e a sorbirsi per sopramercato, la frecciata indiretta, lanciatagli dalla prima attrice Luigia Bon la quale, nel fervorino di congedo, rese omaggio al buon gusto del pubblico bolognese che aveva decisamente preferito le opere del Goldoni a qualsiasi altro spettacolo drammatico.
Testo tratto da: 'Un vice-legato antigoldoniano', in Oreste Trebbi, 'Cronache della vecchia Bologna', Compositori, Bologna, 1937.