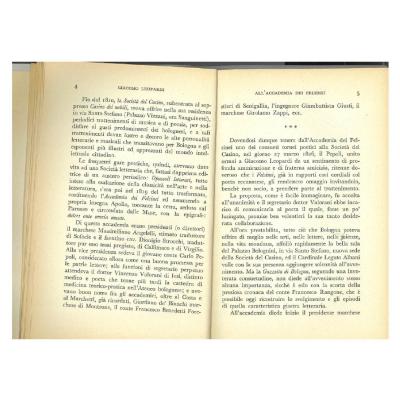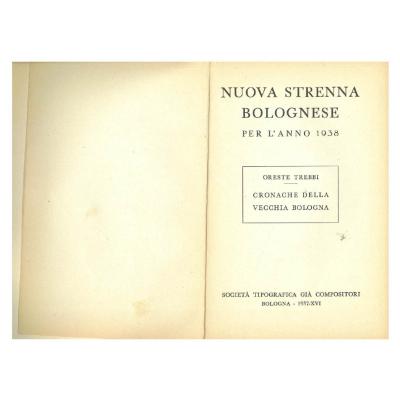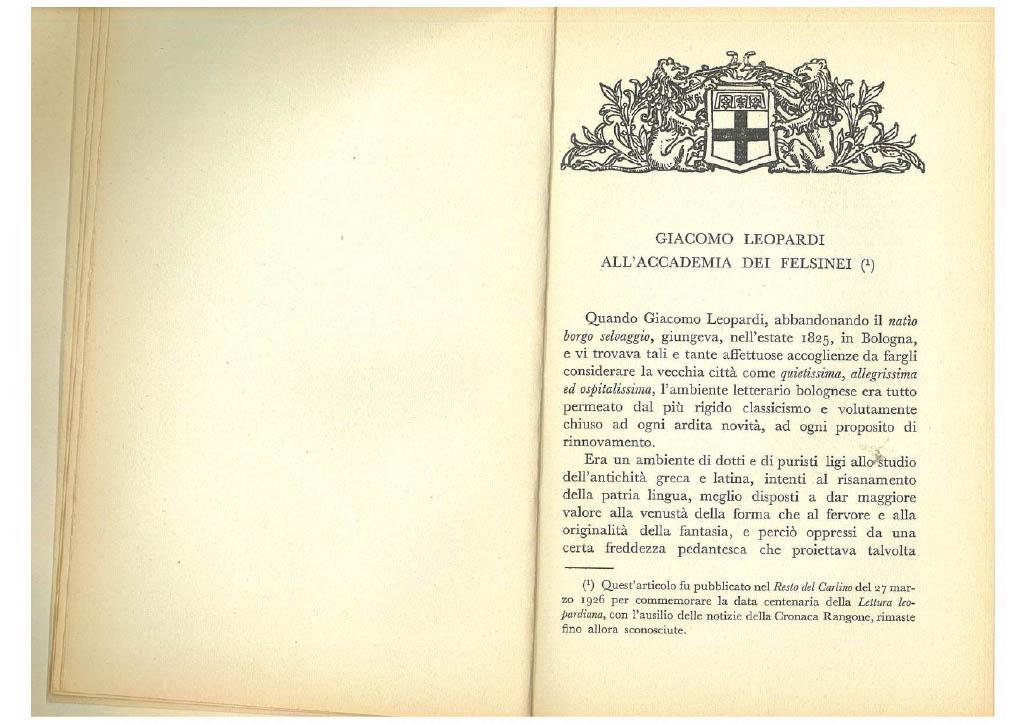Schede
"(Quest'articolo fu pubblicato nel Resto del Carlino del 27 marzo 1926 per commemorare la data centenaria della Lettura leopardiana, con l'ausilio delle notizie della Cronaca Rangone, rimaste fino allora sconosciute)
Quando Giacomo Leopardi, abbandonando il natio borgo selvaggio, giungeva, nell'estate 1825, in Bologna, e vi trovava tali e tante affettuose accoglienze da fargli considerare la vecchia città come quietissima, allegrissima ed ospitalissima, l'ambiente letterario bolognese era tutto permeato dal più rigido classicismo e volutamente chiuso ad ogni ardita novità, ad ogni proposito di rinnovamento. Era un ambiente di dotti e di puristi ligi allo studio dell'antichità greca e latina, intenti al risanamento della patria lingua, meglio disposti a dar maggiore valore alla venustà della forma che al fervore e alla originalità della fantasia, e perciò oppressi da una certa freddezza pedantesca che proiettava talvolta un'ombra sfavorevole sui loro meriti reali di letterati e di sapienti. Fra quei dotti primeggiavano il ravennate Paolo Costa e il senigalliese conte Giovanni Marchetti, scrittori entrambi di bella fama e di riconosciuta autorità e intorno ad essi gravitava lo stuolo degli astri minori e dei satelliti aderenti ai canoni di quella Scuola letteraria romagnola che aveva per metropoli Bologna, che vantava il consenso dei più eletti prosatori e poeti della Romagna e delle Marche e considerava come suoi numi tutelari Vincenzo Monti e Pietro Giordani. Un tale ambiente quindi, sia per l'affinità degli studi, sia per il gusto educato alla severità dell'arte, era forse più d'ogni altro predisposto al riconoscimento dell'alta personalità del Leopardi ed all'accoglimento della mirabile opera sua, e perciò i letterati bolognesi apparvero subito al giovane poeta tutti di buon cuore e prevenuti favorevolmente per lui. D'altra parte egli usò con essi un tale contegno da conquistarne gli animi senza fatica, sicchè dopo pochi mesi di convivenza potè scrivere al fratello Carlo: «Questi letterati che da principio, come mi è stato detto e ridetto, mi guardavano con invidia e con sospetto grande, perchè credevano di dovermi trovare superbo e disposto a soverchiarli, sono poi stati contentissimi della mia affabilità, e di vedere che io lascio luogo a tutti: dicono finora un gran bene di me, vengono a trovarmi e sento che stimano un acquisto per Bologna la mia presenza».
Ma la quotidiana dimestichezza con gli scrittori petroniani non rivelò solamente all'attento ed acuto osservatore la loro cortesia e la loro bonarietà, ma gli offri la possibilità di valutarli e di giudicarli adeguatamente. Per questa ragione, allorchè egli passò a Firenze e mise a confronto i due diversi ambienti letterari, scrisse al padre che i fiorentini generalmente pensavano e valevano assai più dei bolognesi. Nel suo giudizio il Leopardi mostrava di valutare non solo l'ingegno e la dottrina, ma anche l'attività del pensiero, giacchè egli teneva in gran conto le discipline filosofiche che a Bologna invece godevano di un culto assai limitato. Gli uomini di lettere della vecchia città erano forse più grammatici che pensatori, ed eccellenti nel tradurre versi e prose dell'età classica, si piccavano d'essere un po' tutti figli prediletti delle Muse. «In questa benedetta Bologna, diceva infatti il Leopardi, pare che letterato e poeta o piuttosto verseggiatore, siano parole sinonime. Tutti vogliono far versi...». Ora questa specie di frenesia poetica non era fenomeno del momento, ma aveva origini assai lontane e risaliva ai placidi tempi in cui l'arcadia signoreggiava e cento e più accademie offrivano ricetto alla oziosa vacuità delle classi sociali più elevate. Il turbine napoleonico non era riuscito nè a frenarla, nè a limitarla,e perciò anche ll'ombra delle aquile imperiali essa aveva continuato a prosperare, trovando poscia, al giungere della Restaurazione, nuove e più favorevoli condizioni alla sua espansiva vitalità. Un'ombra sfavorevole sui loro meriti reali di letterati e di sapienti. Fra quei dotti primeggiavano il ravennate Paolo Costa e il senigalliese conte Giovanni Marchetti, scrittori entrambi di bella fama e di riconosciuta autorità e intorno ad essi gravitava lo stuolo degli astri minori e dei satelliti aderenti ai canoni di quella Scuola letteraria romagnola che aveva per metropoli Bologna, che vantava il consenso dei più cletti prosatori e poeti della Romagna e delle Marche e considerava come suoi numi tutclari Vincenzo Monti e Pietro Giordani. Un tale ambiente quindi, sia per l'affinità degli studi, sia per il gusto educato alla severità dell'arte, era forse più d'ogni altro predisposto al riconoscimento dell'alta personalità del Leopardi ed all'accoglimento della mirabile opera sua, e perciò i letterati bolognesi apparvero subito al giovane poeta tutti di buon cuore e prevenuti favorevolmente per lui. D'altra parte egli usò con essi un tale contegno da conquistarne gli animi senza fatica, sicchè dopo pochi mesi di convivenza potè scrivere al fratello Carlo: «Questi letterati che da principio, come mi è stato detto e ridetto, mi guardavano con invidia e con sospetto grande, perchè credevano di dovermi trovare superbo e disposto a soverchiarli, sono poi stati contentissimi della mia affabilità, e di vedere che io lascio luogo a tutti: dicono finora un gran bene di me, vengono a trovarmi e sento che stimano un acquisto per Bologna la mia presenza». Ma la quotidiana dimestichezza con gli scrittori petroniani non rivelò solamente all'attento ed acuto osservatore la loro cortesia e la loro bonarietà, ma gli offri la possibilità di valutarli e di giudicarli adeguatamente. Per questa ragione, allorchè egli passò a Firenze e mise a confronto i due diversi ambienti letterari, scrisse al padre che i fiorentini generalmente pensavano e valevano assai più dei bolognesi. Nel suo giudizio il Leopardi mostrava di valutare non solo l'ingegno e la dottrina, ma anche l'attività del pensiero, giacchè egli teneva in gran conto le discipline filosofiche che a Bologna invece godevano di un culto assai limitato. Gli uomini di lettere della vecchia città erano forse più grammatici che pensatori, ed eccellenti nel tradurre versi e prose dell'età classica, si piccavano d'essere un po' tutti figli prediletti delle Muse. « In questa benedetta Bologna, diceva infatti il Leopardi, pare che letterato e poeta o piuttosto verseggiatore, siano parole sinonime. Tutti vogliono far versi...». Ora questa specie di frenesia poetica non era fenomeno del momento, ma aveva origini assai lontane e risaliva ai placidi tempi in cui l'arcadia signoreggiava e cento e più accademie offrivano ricetto alla oziosa vacuità delle classi sociali più elevate. Il turbine napoleonico non era riuscito nè a frenarla, nè a limitarla, e perciò anche all'ombra delle aquile imperiali essa aveva continuato a prosperare, trovando poscia, al giungere della Restaurazione, nuove e più favorevoli condizioni alla sua espansiva vitalità. Fin dal 1810, la Società del Casino, subentrata al soppresso asino dei nobili, usava offrire nella sua residenza in via Santo Stefano (Palazzo Vizzani, ora Sanguinetti), periodici trattenimenti di musica e di poesia, per soddisfare ai gusti predominanti dei bolognesi, e a tali trattenimenti davan lustro e decoro le alte personalità letterarie e musicali che transitavano per Bologna e gli esponenti più illustri ed apprezzati del mondo intellettuale cittadino. Le frequenti gare poetiche, quindi, avevano dato vita ad una Società letteraria che, fattasi dapprima editrice di un austero periodico: Opuscoli letterari, tutto inteso alla esaltazione della classicità nell'arte e nella letteratura, s'era poi nel 1819 del tutto trasformata, costituendo l'Accademia dei Felsinei ed assumendo a propria insegna Apollo, toccante la cetra, seduto sul Parnaso e circondato dalle Muse, con la epigrafe: dulces ante omnia musce. Di questa accademia erano presidenti (o direttori) il marchese Massimiliano Angelelli, stimato traduttore di Sofocle e il faentino cav. Dionigio Strocchi, traduttore pur esso assai pregiato, di Callimaco e di Virgilio. Alla vice presidenza sedeva il giovane conte Carlo Pepoli, considerato allora come una buona promessa per le patrie lettere; alle funzioni di segretario perpetuo attendeva il dottor Vincenzo Valorani di Iesi, distinto medico e poeta che tenne più tardi la cattedra di medicina teorico-pratica nell'Ateneo bolognese; e avevano buon nome fra gli accademici, oltre al Costa e al Marchetti, già ricordati, Giordano de' Bianchi marchese di Montrone, il conte Francesco Benedetti Forestieri di Senigallia, l'ingegnere Giambattista Giusti, il marchese Girolamo Zappi, ecc. Dovendosi dunque tenere dall'Accademia dei Felsinei uno dei consueti tornei poetici alla Società del Casino, nel giorno 27 marzo 1826, il Pepoli, unito ormai a Giacomo Leopardi da un sentimento di profonda ammirazione e di fraterna amicizia, ritenne doveroso che i Felsinei, già in rapporti così cordiali col poeta recanatese, gli rendessero omaggio invitandolo, benchè non socio, a prendere parte al trattenimento. La proposta, come è facile immaginare, fu accolta all'unanimità e il segretario dottor Valorani ebbe incarico di comunicarla al poeta il quale, forse un po' lusingato, promise ben volentieri la sua tanto desiderata collaborazione. All'ora prestabilita, tutto ciò che Bologna poteva offrire di meglio nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, nella vita mondana, affollò rapidamente la bella sala del Palazzo Bolognini, in via Santo Stefano, nuova sede della Società del Casino, ed il Cardinale Legato Albani volle con la sua presenza aggiungere solennità all'avvenimento. Ma la Gazzetta di Bologna, seguendo una inveterata consuetudine, non diede notizia all'avvenimento stesso. alcuna importanza, sicchè è solo con la scorta della preziosa cronaca del conte Francesco Rangone, che è possibile oggi ricostruire lo svolgimento e gli episodi di quella caratteristica giostra letteraria. All'accademia diede inizio il presidente marchese Angelelli con un breve e piacevole discorso inteso a ricordare che alle Muse sempre tornarono graditi la della sua tristezza, piacque e trovò larga cordialità di lietezza dell'animo ed i giocondi pensieri, e l'uditorio traendo da tale discorso favorevoli auspici, lo salutò con una calda acclamazione. Ma il dottor Valorani che dopo di lui prese la parola, dissertando «sulla pace e sulla tranquillità di che son cagione gli studi» parve animato dal proposito di togliere agli ascoltatori ogni speranza di confortevole diletto. Per oltre un'ora egli parlò prolisso e grave, mentre una noia infinita diffondendosi via via per la sala, suscitava nel pubblico un tale stato d'insofferenza da indurlo a dimenticare le regole della buona creanza ed a troncare la parola dell'opprimente oratore con uno scrosciante applauso, tanto eloquente quanto intempestivo. Al dottor Valorani successe l'ingegner Giusti, amico intimo di Gioachino Rossini ed amico ancor più intimo della bella Cornelia Martinetti. Egli lesse un mediocre sermone sul «Matrimonio» che non gli cattivò troppe simpatie. La sua ardita libertà di linguaggio fu giudicata, al dire del Rangone, sconveniente ed eccessiva, ed il suo modo di porgere, parve il riflesso di una insolente superiorità. Seguì poscia l'epigrafista toscano Luigi Muzzi con un sonetto esaltante i benefici della solitudine, indi il marchese Antonio Tanari, con discutibile opportunità, trasse l'udienza a meditare sulla morte e sui sepolcri. Decisamente i giocondi pensieri cari alle Muse non accendevano in quel giorno la fantasia dei poeti! E infatti anche il conte Carlo Pepoli, il futuro librettista dei Puritani, declamò La Miosotide palustre, una novella drammatica in cui amore e morte avevano alterna vicenda. la novella tuttavia, ad onta della sua tristezza, piacque e trovò larga cordialità di consensi. Dopo il Pepoli venne la volta del Leopardi, e un senso di curiosa attesa si diffuse subito nella sala a suo riguardo.
Noti erano ai più il suo nome e il suo alto valore, ma erano note altresì le sue peripezie famigliari, le strettezze economiche in cui viveva, e il suo umore melanconico e lo stato cagionevole della sua salute che lo tenevano forzatamente lontano dai pranzi e dai convegni del mondo elegante e della buona società. Non tutti quindi lo conoscevano di persona, sicchè quando egli si alzò e apparve così fisicamente disgraziato, pallido, smunto, gobbo e mingherlino, un senso di penosa disillusione s'impadroni del pubblico, il quale purtroppo ha sempre cercato in ogni tempo, nei conferenzieri e nei declamatori, anche i doni naturali necessari a richiamare la sua attenzione, ad ispirare la sua simpatia. E allorquando l'infelice poeta incominciò, con la più assoluta assenza di lenocini oratorii, a leggere la Epistola a Carlo Pepoli, che se non è oggi considerata fra le sue opere di maggior conto, valeva certo da sola più di tutte le prose e le poesie declamate in quell'accademia, pochi seppero ascoltarlo con amorevole condiscendenza. L'uditorio era stanco ed annoiato, e nuovi versi ispirati a malinconiche considerazioni, dovettero aggravare il suo già troppo vivo senso di malessere; perciò il Rangone afferma che il Leopardi disse certamente delle bellissime cose, ma nessuno le comprese, mentre in molti restò il desiderio di veder presto stampato il componimento per poterlo leggere ed apprezzare con maggiore tranquillità. Ma nelle anormali condizioni di spirito degli ascoltatori, va ricercata inoltre la giustificazione della accoglienza calorosissima ottenuta successivamente dal marchese Zappi con le sue tornite e sonanti ottave sull'invenzione mitologica dello specchio. Il Zappi fu l'unico poeta che seppe scegliere un argomento dilettevole e, per ragioni di contrasto, meritò quindi le schiette attestazioni della pubblica riconoscenza. Infine, dopo un sonetto di Ignazio Borzaghi, affermante che la vera sapienza è sempre da pochi conosciuta ed onorata, il conte Giovanni Marchetti pose fine al trattenimento declamando l'ode Alla necessità, che è fra le sue liriche più pregiate, ed alla quale fu riconosciuto, in quel giorno, un primato indiscusso. Il Leopardi intanto, congedandosi dagli amici, donava al Pepoli il manoscritto della sua Epistola, che poi, in copie, veniva diffusa per la città. Egli era stato, con pietosa menzogna, assicurato del felice esito della sua declamazione, e perciò scrivendo al fratello Carlo per raccontargli l'accaduto, aggiungeva candidamente: «Mi dicono che i miei versi facessero molto effetto, e che tutti, donne e uomini, li vogliono leggere», e Carlo, ben lieto, si rallegrava con lui, «perchè, diceva, il successo è cosa che molto rassomiglia alla felicità». ALBICINI CESARE
BIBLIOGRAFIA Prefazione alle: Prose e poesie di Carlo Pepoli, vol. I. Bologna, 880. Epistolario di Giacomo Leopardi. Firenze, 1924, vol. II. Lettere 320, 344, 406, 425, 506. Lettere scritte a Giacomo Leopardi dai suoi parenti. Firenze, 1878. Lettera 86. MEDICI MICHELE: Memorie istoriche intorno le Accademie scientifiche e letterarie della città di Bologna. Ivi, 1852. RANGONE FRANCESCO: Cronaca bolognese manoscritta (presso la Biblioteca dell'Archiginnasio). 1826, 2º trimestre." Testo tratto da: Oreste Trebbi, 'Cronache della vecchia bologna', Società tipografica già Compositori, Bologna, 1937.